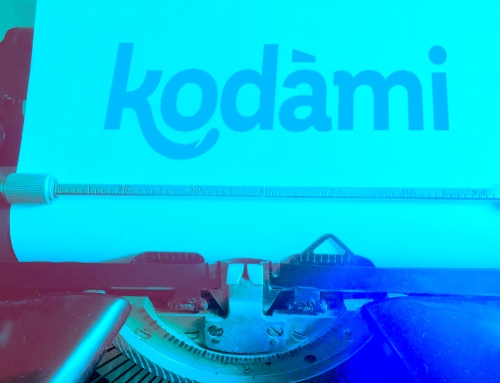L’uomo vede il mondo dal punto di vista dell’uomo. Beh, certo. Probabilmente la zanzara vede il mondo dal punto di vista della zanzara (accidenti a lei!), così come il gatto o il cane o l’elefante vedono il mondo dal loro punto di vista. Ogni specie vede il mondo così come gli serve, per la sua vita e la sua prosperità. O meglio, ogni specie vede del mondo ciò che gli serve e nulla di più. Possiamo comprenderlo partendo dai sensi e da come questi inviino informazioni al cervello di ogni animale. Per esempio, il cervello umano è in grado di rilevare solo una piccola porzione dello spettro luminoso che attraversa la pupilla, e che sollecita la retina con i suoi coni e bastoncelli. L’uomo vede ed elabora lo spettro luminoso che gli serve per la specie animale che è. Evidentemente gli infrarossi e gli ultravioletti (per fare un esempio) non hanno rilevanza per la nostra specie, quindi, pur attraversando anch’essi la nostra pupilla, non ci sono strumenti nella retina affinché il nostro cervello li possa elaborare e registrare, in sostanza non abbiamo alcun organo di senso che consenta al nostro cervello di registrare gli infrarossi, come ad esempio posso fare i serpenti grazie a delle particolari fossette (pit) poste sulla testa (un articolo di approfondimento).
Ciò vale anche per quanto riguarda i suoni, gli odori, la sensibilità tattile e così via.
Ecco che allora i differenti sistemi cognitivi elaborano gli input rilevanti ed ignorano gli altri, perciò ne consegue che ogni forma di intelligenza agisce su pacchetti di informazioni differenti per scopi differenti. Questo rende impossibile paragonare un’intelligenza all’altra dato che hanno funzionalità e scopi ben differenti.
Torniamo al fatto che noi vediamo il mondo dal nostro punto di vista. Se vogliamo comprendere come gli altri animali stanno nel mondo, come agiscono e come risolvono i loro problemi per sopravvivere e trasmettere il loro patrimonio genetico alle generazioni future, se lo vogliamo veramente, dobbiamo compiere una difficile operazione, ossia tentare di vedere il mondo dal loro punto di vista. E come possiamo farlo? Sforzandoci di conoscerli più a fondo possibile abbandonando preconcetti e strutture percettive e cognitive propriamente nostre. In sostanza contrastando il naturale antropocentrismo che ci è proprio.
Non è affatto facile, certo, ma comprendere l’altro da me diviene impossibile quando non faccio altro che proiettare su di lui me stesso. Vero è che, anche quando riuscissi a farlo, le cose non sarebbe molto semplici. Il parere di alcuni blasonati etologi e filosofi, come Thomas Nagel, che nel 1974 si pose il quesito:
Cosa si prova ad essere un pipistrello?
Concluse che, ahimé, non lo avrebbe mai saputo. Sostenne che non avremmo mai potuto entrare nella vita soggettiva di un’altra specie animale.
Vero. Forse un giorno le cose cambieranno grazie a chissà quale diavoleria tecnologica, ma sta di fatto che oggi, se abbandoniamo certi filtri che ci rendono ciechi, pur non potendo in prima persona entrare nel mondo degli altri animali (e spesso nemmeno nel mondo di altri esseri umani) potremmo però, quel mondo, farcelo raccontare direttamente da loro. Certamente il cane in questo è la specie eletta. Quella che ci può fare da ponte, se non altro per la sua propensione a comunicare ed empatizzare con noi.
Facciamo qualche esempio di antropocentrismo limitante: siamo soliti applicare la struttura sociale umana agli altri animali; parliamo di Ape Regina e Ape Operaia, oppure della sovranità di un animale sugli altri, il Leone è il Re della foresta. Siamo anche soliti descrivere la relazione con i nostri cani alla stregua di una struttura militarizzata, che contempla i vari gradi di autorità e inferiorità o, ancora, applichiamo il “modello del Lavoratore” che ha dei doveri nei confronti del Datore di Lavoro per ottenere delle ricompense in cambio della fatica, che è soggetto a “punizioni” quando non è produttivo come ci si aspetterebbe, come da contratto. Ma si può dire che il border collie, quando raduna un greggie, “stia lavorando”? Intendendo per “lavoro” un’attività impegnativa che si fa in funzione di una ricompensa diversa dal lavoro stesso? Mi spiego meglio: il leone, quando caccia la zebra, sta lavorando? È certamente vero che la caccia del leone è funzionale alla sua sopravvivenza, ma siamo certi che sia paragonabile al lavoro così come ce lo figuriamo noi? Per lo più (grazie al Cielo, non è sempre così) traducibile con: Fare qualcosa che non mi andrebbe di fare ma che faccio per senso del dovere e per causa di forza maggiore?
Credo di poter affermare – e me ne assumo tutte le responsabilità – che:
Solo l’uomo ha il concetto di lavoro!
Il fatto è che, man mano si procede nella conoscenza degli altri animali, il piedistallo dell’uomo, come vertice evolutivo, come supremo esempio di natura, come origine di ogni facoltà “superiore”, si sgretola inesorabilmente.
Quante volte si è sentito dire – o vistro scrivere – in ambito scientifico cose come:
Questa caratteristica, che si attribuiva esclusivamente all’uomo, invece si è scoperta anche in questo o quell’altro animale…
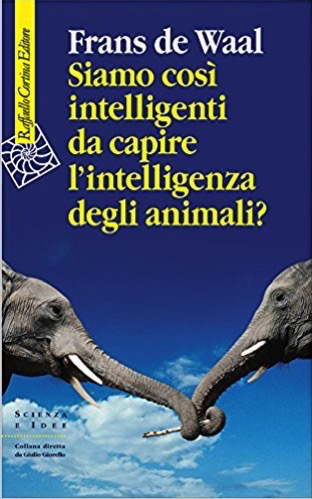 E qui un lungo elenco di cose: le emozioni; prima le aveva solo l’uomo, poi si sono – ovviamente – osservate anche negli altri animali; le facoltà cognitive (discriminazione, categorizzazione, inferenza, eccetera); la consapevolezza del sé (Self Recognizing Test, o test dello specchio) attribuita esclusivamente all’uomo, dimostrata anche in molte altre specie animali (scimpanzè Bonobo, Orche, Delfini, Elefanti, Gazze Europee, eccetera) e così via.
E qui un lungo elenco di cose: le emozioni; prima le aveva solo l’uomo, poi si sono – ovviamente – osservate anche negli altri animali; le facoltà cognitive (discriminazione, categorizzazione, inferenza, eccetera); la consapevolezza del sé (Self Recognizing Test, o test dello specchio) attribuita esclusivamente all’uomo, dimostrata anche in molte altre specie animali (scimpanzè Bonobo, Orche, Delfini, Elefanti, Gazze Europee, eccetera) e così via.
Non è mica cosa da poco riuscire a scoprire ed osservare scientificamente (seguendo cioé i dettami del Metodo Scientifico Galileano) determinate cose, anche quando sono una lapalissiana realtà.
Ci sono molti testi che trattano questo interessante argomento e ne voglio citare qui uno degli ultimi che mi è capitato per le mani: Siamo così intelligenti da capire l’intelligenza degli animali? di Franse De Waal (Raffaello Cortina Editore, 2016).
Nella prima parte del testo l’autore ci accompagna indietro nel tempo agli albori dello studio del comportamento animale, fino ad arrivare alla cognizione animale, mostrando con grande chiarezza d’esposizione, quali siano state le difficoltà in ambiente accademico nel superare una visione antropocentrica lasciando campo libero all’espressione comportamentale dalla quale evincere i complessi processi cognitivi che guidano anche le altre creature. Un pensiero mi è nato leggendo quelle pagine:
La scienza, spesso, deve faticare immensamente per dimostrare l’ovvio.
Come si legge nel testo succitato e da altre considerazioni, alle volte gli animali altri-da-noi si sono dimostrati poco intelligenti a causa del fatto che noi gli si ponevano domande sbagliate – o nel modo sbagliato – non tenendo in conto il loro modo di percepire il mondo e di dare rilievo a certe cose piuttosto che ad altre, semplicemente perché si dava per scontato il “nostro” punto di vista, il nostro mondo percettivo e complesso di valori.
Ma cosa accade quando l’uomo si trova di fronte a sensi e percezioni che lui non possiede, come nel caso dell’ecolocalizzazione tipica di alcuni animali, per esempio dei pipistrelli e dei cetacei?
Un libro, che segnò un importante svolta nel modo di studiare e conceperire il posto dell’uomo nei confronti degli altri animali, fu segnato da Donald Griffin (detto scherzosamente dai colleghi il batman) con il suo libro “L’ANIMALE CONSAPEVOLE” (1979) in cui (cito dal testo di De Wall):
[l’autore, D. Griffin] lamentava dell’errata percezione che tutto nel mondo ruoti intorno a noi…
Pare che nella storia l’uomo abbia sempre cercato di dimostrare a sé stesso di essere profondamente diverso da tutte le altre forme di vita sul pianeta; diverso e – naturalmente – superiore, tanto da considerare l’animale come indice regressivo dell’uomano. Una specie di “luogo” ove espiare i propri peccati e il proprio tormento. Divenire animali (o meglio: Bestie) assume il significato di “perdere la propria umanità” e tornare ad essere beluini, maligni e furiosi, privi di controllo e qualunque buona qualità. Tutto ciò rientra in un tema caldo, e mi azzardo a dire “cardine” del nostro tempo, ovvero la lotta all’antropocentrismo per liberare noi stessi da freni e barriere culturali e vivere il fascino della vita in quanto tale.
A tal proposito cito qui un’interessante intervista al prof. Roberto Marchesini, riconosciuto tra i maggiori filosofi dell’etologia, autore di un grande numero di saggi, tra i quali ricordo “POST-HUMAN. Verso nuovi modelli di esistenza.” Edito da Bollati Boringhieri (2002) e il più recente “INTELLIGENZE PLURIME”, Oasi Alberto Perdisa Editore (2008)
Ora, l’argomento è estremamente interessante e potremmo continuare a parlarne all’infinito, ma quello che mi ha sollecitato questo articolo è stato un pezzo riportato sulla Repubblica di un paio di giorni fa, dal titolo “CARO PADRONE SEI PROPRIO INGIUSTO”. COSÍ I CANI RICONOSCONO I TORTI SUBITI, a firma di Emilio Vitaliano.

L’intero articolo apparso il 10 Giugno 2017 su La Repubblica
Dell’articolo mi hanno colpito un paio di cose di cui vorrei fare menzione e sulle quali spendere brevi considerazioni.
In particolare due affermazioni hanno catturato la mia attenzione, al di là della notizia in sé, sulla quale si potrebbe dibattere molto, ma non prima di aver letto la ricerca vera e propria e non solamente l’articolo riportato da un giornalista, pur bravo e attendibile che sia, che per necessaria brevità ha certamente dovuto operare delle scelte riferendo il cuore della notizia le cui sfumature però, se si parla di scienza, vanno certamente approfondite.
Eccoci di nuovo, il preconcetto:

Finora si riteneva che il forte senso di giustizia dei cani derivasse dalla loro millenaria coabitazione con gli umani.
Ma certo! E come, se non dagli umani, i cani avrebbero potuto maturare un “forte senso di giustizia”? Impensabile che altre specie sociali possano sviluppare – in milioni di anni di storia evoluzionistica – l’altruismo e il senso del giusto e dello sbagliato, e quindi provare emozioni come il disappunto e, addirittura, la rabbia per un torto se non apprendendolo dagli ultimi arrivati sul pianeta, ovvero dagli esseri umani? Aspettavano tutti quanti noi per imparare a convivere…
Ma ecco la chicca, che ci vuole sempre per mettere le mani avanti, prima di commettere un cataclismico errore di valutazione:
“Non so se si può parlare di senso di giustizia nei cani, significherebbe attribuire agli animali sensazioni e valori tipici degli esseri umani» spiega Luigi Boitani, zoologo presso l’Università La Sapienza di Roma e grande studioso di lupi.

Come leggiamo questa affermazione riportata dal giornalista (si spera fedelmente) del ben noto studioso Luigi Boitani?
Egli mette l’accento sul fatto che si può commettere l’errore di attribuire qualità (o difetti) tipicamente umani anche agli altri animali, ossia avverte del possibile errore di antropocentrismo.
Si è dunque portati alla cautela per evitare di fraintendere quanto affermato nella ricerca (che però non ho ancora letto dalla fonte, come detto, e cercherò in questi giorni di reperire il testo in originale per eliminare il rischio dell’interpretazione errata o “creativa” dell’autore dell’articolo).
Ma, attenzione!
Questa affermazione significa che ai cani non vanno attribuite caratteristiche umane superiori per le quali non possono essere dotati in quanto specie “inferiore” all’uomo? Oppure significa che la prospettiva del cane sul mondo è talmente differente dalla nostra che forse, per certi comportamenti ed atteggiamenti, non è possibile fare una comparazione con gli stessi prodotti da una specie molto differente, quale è la nostra?
Credo che si dovrebbero abbandonare certe reticenze e affrontare l’indagine sulla conoscenza della vita e delle sue infinite manifestazioni liberi da preconcetti, paure e arcaici costrutti culturali che altro non fanno che creare impedimenti.
Non esisteno specie superiori e specie inferiori.
L’uomo è una delle tante forme di vita animale di questo pianeta ed è dotato di grande curiosità, il quale dovrebbe abbandonare l’arroganza e l’auto-compiacimento finalizzati al giustificare tutte le nefandezze di cui lui (e solo lui) è capace nei confronti degli altri da sé.